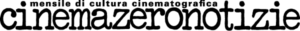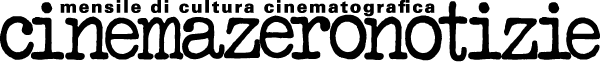IDFA 2021, premi a volte incomprensibili ci dicono (un po’) del documentario di oggi

Di Riccardo Costantini
“Grande la confusione sotto il cielo”, diceva quello. Certo che – complice la pandemia – si produce meno e peggio, ma alle volte, nel partecipare alla 34 edizione del più grande al festival di documentario al mondo, si è avuta forse la certezza che troppo sovente i registi cerchino a tutti i costi l’originalità, e – più di tutto – che la selezione poteva essere fatta con un po’ più di severità, o quanto meno i premi – specchio e cartina di tornasole di un festival – potessero esser dati con più rigore. Al Festival del Documentario di Amsterdam (IDFA) i bookmakers non accettavano scommesse: in un concorso internazionale con una selezione di titoli non proprio effervescente, era abbastanza ovvio che il maestro Sergei Loznitsa portasse a casa senza problemi il premio principale l’IDFA Award per il miglior film nella competizione internazionale.
Lo vince per Mr. Landsbergis – dedicato alla secessione lituana dall’Unione Sovietica -, film costruito su una lunga intervista a Vytautas Landsbergis, il primo leader del parlamento lituano dopo la dichiarazione di indipendenza, montata sì magistralmente insieme a moltissimo materiale d’archivio interessantissimo…per una durata però che va oltre le 4 ore e che davvero mette in difficoltà gli spettatori (e le categorie di giudizio). Allo stesso modo, desta una certa perplessità il premio dato al libanese Karim Kassem, vincitore dell’IDFA Award per il miglior film nella competizione Envision con Octopus, che racconta il post disastro dell’esplosione che ha devastato Beirut ad agosto 2020 con un registro sobrio, privilegiando silenzi e micro azioni di ricostruzione, ma senza che il film si spinga molto più in là di una chiave certo originale per raccontare il tutto, che anzi sembra più essere un escamotage di richiamo che una valida soluzione narrativa.
Di tutt’altro appeal è risultato invece O, Collecting Eggs Despite Times, che vince l’IDFA Award per la migliore regia nel Concorso Envision: il regista Pim Zwier dipinge un vivido ritratto di un ornitologo tedesco lavorando su filmati d’archivio che si intrecciano mirabilmente alla storia del protagonista: la storia, originale e curiosa, di un collezionista di uova, si fonde con quella della grande Storia, con l’ascesa del nazismo e la guerra che incombe e poi esplode. Un modo davvero non convenzionale, con l’articolazione di alternanze fra materiali di footage d’eccezione a riprese in dettaglio di pagine di diario, lettere…e migliaia di uova.
Where are we headed?, vincitore del premio per la migliore fotografia nella competizione internazionale e per la migliore opera prima, è invece il sorprendente film di Ruslan Fedotow , che descrive gli imponenti spazi, quasi teatrali, della metropolitana di Mosca, come sfondo di una continua tragicommedia. Un documentario d’osservazione, con la metropolitana e ovviamente i suoi passeggeri protagonisti, fresco, capace anche di articolare una tesi chiara ma ironica, avversa al dispotismo di Putin. Fra piccoli inconvenienti, incontri surreali, conversazioni si crea un’immagine colorata di una società sotterranea in miniatura, una Russia bizzarra e viva, piena di varietà culturali, che viaggia, ma che forse si sta chiedendo dove sta andando…
Se la vita è stata dura per la lavoratrice domestica sudafricana Mothiba Grace Bapela, che l’ha vissuta al servizio degli altri, non fa un servizio né a lei né a un racconto che avrebbe avuto delle possibilità di importanza sociale, il documentario One Take Grace. Nel frattempo, ha perseguito una carriera come attrice. Premiato come contributo artistico d’eccezione, per essere un “toccante ritratto della disuguaglianza sociale e dell’oppressione delle donne”, il film di Lindiwe Matshikiza appare invece come un infelice, soprattutto dal punto di vista tecnico, tentativo di seguire troppo da vicino la vita della protagonista, raggiungendo – per chi scrive – l’esito contrario: un ritratto insopportabile e per nulla rispettoso.