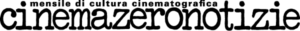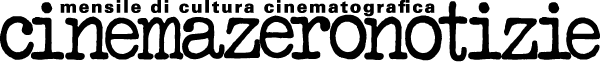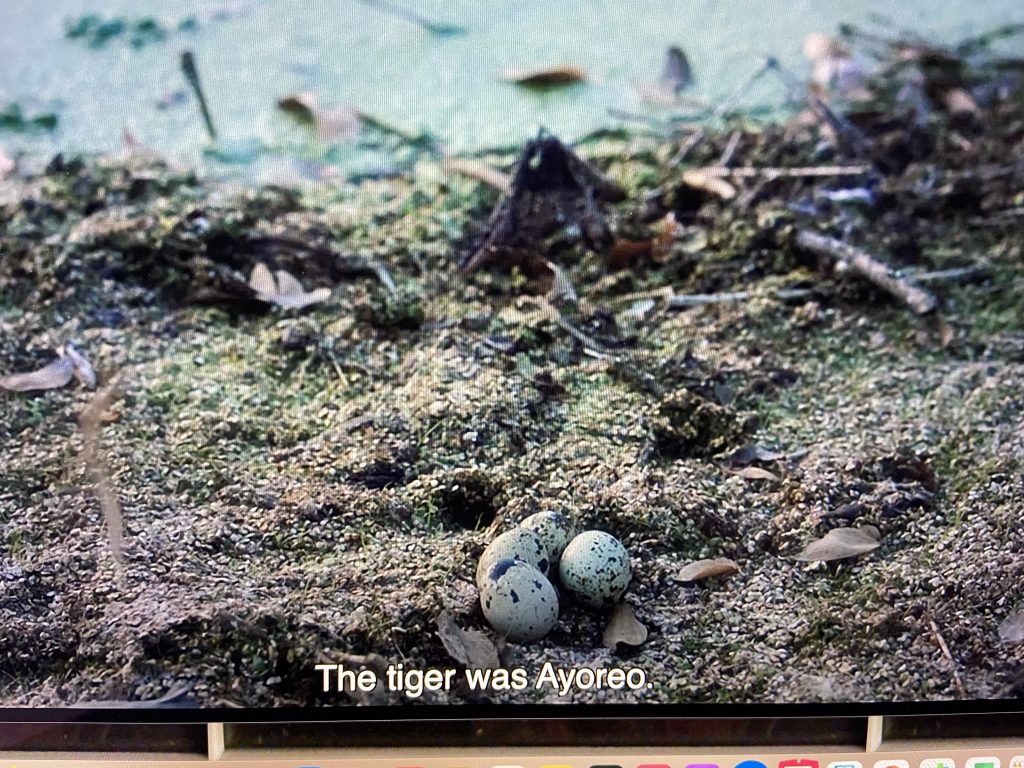Rotterdam: il ruggito della Tigre
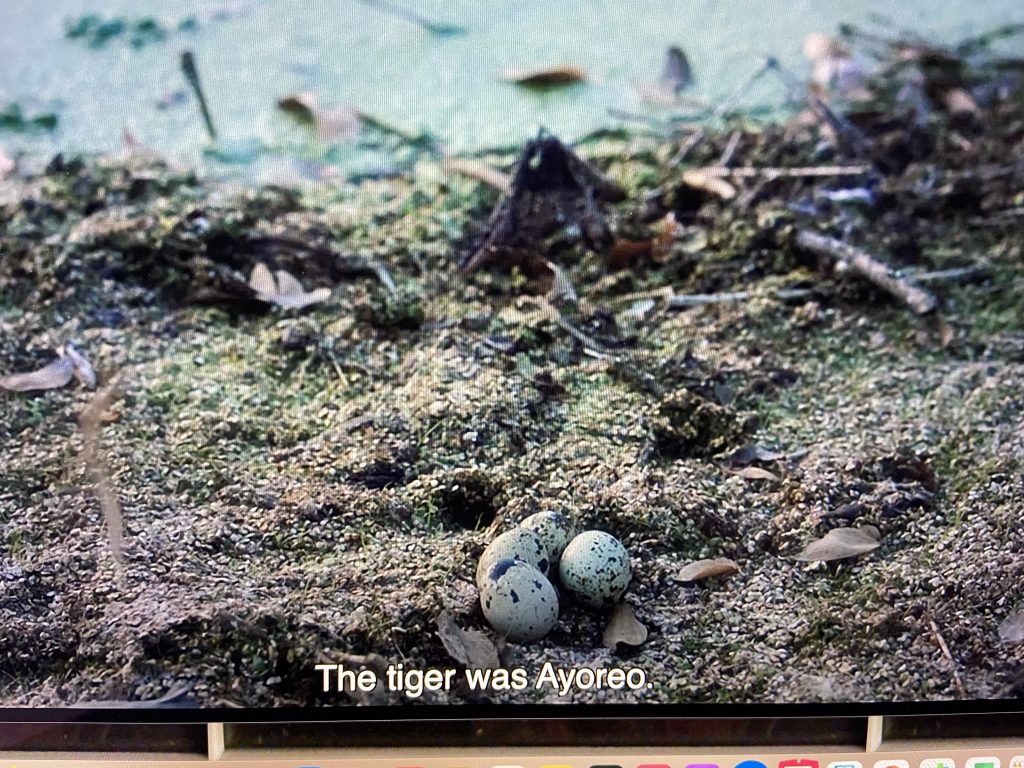
di Andrea Crozzoli
È al 146 della Schiedamse Vest, piccola stradina di Rotterdam a pochi passi dal Cinerama della Westblaak, che si trova l’Hopper Coffee. Un piccolo ed accogliente locale dalla calda e gioviale atmosfera. Luogo molto informale con delle magnifiche zuppe bollenti ed eccellenti bruschette su croccanti fette di pane appena sfornato dopo essere stato impastato davanti ai nostri occhi. È una delle soste obbligate durante le intense proiezioni dell’International Film Festival di Rotterdam.
Purtroppo, per il secondo anno
consecutivo, anche la 51ma edizione è stata costretta dalla pandemia a
svolgersi in remoto. Questo ci ha privato, oltre che dell’Hopper Coffee, anche di quell’allure
percepibile solo in presenza, con il calore del pubblico in sala, gli incontri
con gli autori, i lavori di giuria, etc etc.. Fortunatamente, nonostante il
distanziamento imposto, l’esaustiva sezione ufficiale Tiger Competition ci ha permesso, rimanendo (purtroppo) seduti a
casa propria, di effettuare un emozionante, variegato e alquanto esaustivo giro
del mondo attraverso le quattordici anteprime mondiali selezionate, di giovani
autori alla prima o seconda opera.
L’altro aspetto, infatti, di
notevole interesse a Rotterdam è la vocazione verso il cinema giovane, verso le
promesse del futuro, che ci permettono di comprendere dove le nuove sensibilità
stanno portando l’arte del cinema. Per questo 2022 possiamo sicuramente
affermare che il cinema, presente al 51mo IFFR, nel suo complesso, ha stretto
un legame sempre più forte con la realtà, col mondo che ci circonda. Non è un
caso che il film vincitore del 51mo International Film Festival e del
prestigioso Tiger Award (comprensivo
anche di € 40.000) sia andato al bellissimo lavoro proveniente dal Paraguay EAMI
della regista Paz Encina che, dopo sedici anni dal premio Fipresci vinto a
Cannes con Hamaca Paraguaya, ritorna sugli schermi con questo potente,
poetico lavoro sulla lenta ma inesorabile sparizione del popolo Ayoreo. Siamo
in uno degli ultimi lembi di foresta rimasta nella regione del Chaco in
Paraguay che, secondo uno studio dell’Università del Maryland del 2013, subisce
il più alto tasso di deforestazione al mondo. Questa catastrofe umana,
ambientale e culturale viene raccontata in Eami (che nella lingua degli Ayoreo
ha il doppio significato di ‘foresta’ e di ‘terra’ inteso come mondo) con
incredibile tatto e con grande senso poetico. La popolazione locale, i bambini,
le donne sono ripresi con incredibile sensibilità dalla Encina. Dall’altra
parte gli invasori, restano sempre fuori campo, fuori inquadratura; di loro
udiamo gli spari dei fucili, l’abbaiare feroce dei cani, il crepitio della
foresta che brucia. Questa scelta registica crea nello spettatore un senso di
maggiore inquietudine nei confronti di un nemico feroce, che udiamo senza
vedere. Assistiamo così coscienti e impotenti, ma non per questo meno
colpevoli, alla distruzione degli Ayoreo, di un pacifico popolo dalla profonda
cultura ancestrale. La narrazione della Encina rimane costantemente limpida,
pulita, profondamente poetica ma anche senza sconti pur nella sobrietà delle
immagini che toccano così ancor più le corde dell’indignazione per questo
inutile scempio. E la giuria ha giustamente premiato questo sincero lavoro,
terminando così la motivazione: “Questo
film ci ha dato l’opportunità di sognare e allo stesso tempo la possibilità di
svegliarci.”.
Su questa linea di narrazione
della realtà la sezione Tiger Competition
ha proposto alcuni altri notevoli titoli come il franco-svedese Excess
Will Save Us della giovane regista Morgane Dziurla-Petit in cui si
racconta di un minuscolo paesello nel nord della Francia che mobilita decine di
auto della polizia, dopo una telefonata in cui una donna spaventata afferma di
aver udito degli spari e delle grida tipo “Allah
Akbar!”. Si risolverà tutto in un misunderstanding
in quanto gli spari provenivano da un semplice e ignaro cacciatore di piccioni.
Dziurla-Petit, partendo da un’indagine presso la sua famiglia per allargarla
poi all’intero paesello, firma un film fresco, a tratti divertente nella messa
in scena a volte surreale, con buone soluzioni narrative sempre in bilico tra
fiction e doc. Dieci muniti in meno avrebbero forse giovato al ritmo di questo
lungometraggio che è figlio a sua volta di un corto del 2019 presentato a
ClermontFerrand e in seguito dilatato facendolo diventare un lungometraggio.
Affonda le sue radici nel reale
anche il delicato, minimalista, intimo, film messicano Malintzin 17montato da Mara Polgovsky dopo aver,
casualmente, ritrovato il girato del fratello Eugenio, scomparso a soli 40
anni. È la storia di un uccellino che cova nel suo nido costruito tra i fili di
un palo della corrente elettrica. Un nido a prova di pioggia, smog e
quant’altro; con scoiattoli e uomini che corrono e si aggirano senza sosta e
senza storia. Eugenio Polgovsky ha filmato tutto ciò per mesi dal balcone della
sua casa, interagendo nel contempo con la giovanissima figlia in un rapporto di
grande scambio e confidenza. La vita, la sua quotidianità, ripresa nel suo divenire
e montata infine dalla sorella Mara in un tenero e toccante tranche de vie.
Un pezzo di vita che ritroviamo anche in The
Plains dell’australiano David Easteal che utilizza gli stilemi della docufiction per portarci dentro
l’alienazione del protagonista. Siamo nella realtà suburbana di Melbourne e del
suo straniante quotidiano, inesorabile ripetersi. Potremmo anche chiamarlo Alle cinque della sera, come la famosa
poesia di Garcia Lorca, in quanto è proprio alle cinque della sera che questo
avvocato australiano, alle soglie della pensione, esce dal lavoro e torna a
casa con la sua automobile in una sorta di coazione a ripetere, caratteristica
della natura iterativa del pendolarismo. Easteal cura regia, scrittura,
montaggio e scenografia, scandite in sole undici lunghissime sequenze (che si
svolgono in stagioni visibilmente diverse), dove in cinque di queste sequenze
assume anche il ruolo di compagno di viaggio e collega dell’avvocato. Un
insolito e intrigante “road movie ”, dagli aspetti inquietanti in quanto
la vita appare unicamente come l’ennesima fatica di svegliarsi, di andare al
lavoro e di tornare a casa. Qualcosa di assimilabile al criceto nella sua
ruota. The Plains coinvolge e cattura lo spettatore senza annoiare,
nonostante le quasi tre ore di proiezione in un solo ambiente: l’abitacolo
dell’automobile con gli occupanti ripresi sempre di spalle. Una location che,
pur avendo molti precedenti famosi nel cinema, riserva in questo caso nuove
piacevoli novità e sorprese.
Siamo sempre dalle parti del docufiction anche con Proyecto
Fantasma del cileno Roberto Doveris. Con quest’opera indie,
interpretata dall’ottimo Juan Cano, e girata tutta nell’appartamento di
proprietà del regista stesso, si dipanano situazioni ed episodi realmente
accaduti a Doveris nel corso del tempo. Il film mette in scena questo giovane
aspirante attore in cerca di scritture e progetti sui quali spendersi. Doveris
recita anche nel film, oltre a curare la regia, per offrire una
rappresentazione ancor più veritiera e autentica dello stile di vita odierno
dei giovani, non solo cileni, cresciuti sotto gli effetti di youtuber, di
influencer e di una sessualità fluida vissuta nell’assoluta normalità e senza
particolari problemi. Sessualità fluida che ritroviamo anche in Kafka
for Kids dell’israeliano Roee Rosen, un pittore, artista, regista che
ha tra le sue più grandi passioni proprio Kafka e il suo romanzo più famoso “The Metamorphosis”. Con un impianto
visivo che potrebbe anche ricordare, per certi versi, Georges Méliès, con
scenografie di cartone e gli attori parte integrante di oggetti come il
paralume o il cuscino, Rosen sembra rivolgersi ad una specie di tv dei ragazzi
dove i bambini però sono adulti. A due terzi il film vira dall’impianto
surreale e naif a indagine documentaristica sui modi in cui la giovinezza viene
definita dalla legge militare israeliana nei territori occupati. Infatti i
territori occupati offrono una doppia legge: i coloni sono governati secondo la
legge israeliana mentre i palestinesi sono sotto la legge militare, con una
definizione quindi molto diversa. Analoga fluidità la ritroiviamo anche nel
caustico Met mes dell’olandese Sam
de Jong. Un film ultra pop, dai colori sgargianti, iperrealisti, con
grandangoli molto spinti e movimenti di macchina frenetici. Con un insolito e
originale punto di vista della macchina da presa in soggettiva con la pallina
del gioco del volano. Macchina da presa che vola così da una racchetta
all’altra in questa storia di coltelli e bugie (come sempre dalle gambe corte)
per raccontare il frenetico mondo dei giovani d’oggi, che vivono fluidamente,
senza obsoleti tabù o inibizioni. Alla fine il protagonista, però, verbalizzerà
il suo più grande desiderio: «Vivere
senza Internet!».
In bilico fra documentario e
fiction il film cinese Silver Bird and Rainbow Fish di Lei
Lei, un’emergente giovane regista di Pechino che mescola diversi livelli visivi
e narrativi: dallo stop motion in cui modella dell’argilla, a riprese di
vecchie foto di famiglia, a filmati documentari e animazioni pop-art, il tutto
per esplorare temi come la memoria e la sua percezione. Ne risulta un
avvincente e affascinante percorso sulla potenza della nostalgia, sentimento
che fonde una forte storia familiare con la storia del paese in
un’ambientazione potente ed evocativa, durante uno dei più cruciali momenti
storico/politico della Cina di Mao.
Sempre dalla Cina anche To
Love Again opera prima del giovane regista Gao Linyang, già apprezzato
sceneggiatore. Il trentunenne Linyang con incredibile maturità ha scritto e
diretto questo film che affronta le vicende di una coppia della terza età nella
Cina odierna. Come tutte le coppie che hanno un lungo vissuto alle spalle anche
i protagonisti di questa storia devono fare i conti col loro passato, trascorso
nella Cina negli anni ’80, e col presente dove i riti sono sempre collettivi:
dal matrimonio ai funerali. La scrittura e la regia di questo film alternano
sapientemente momenti drammatici e situazioni più leggere, tanto da far
credere, alla fine, di essere quasi difronte a un documentario. Un curioso
contrappunto, nell’ambientazione cinese del film, è rappresentato dalla colonna
sonora di sapore occidentale che richiama alla memoria gli splendidi accordi di
chitarra di Ry Cooder in Paris Texas. Il film ha vinto il
premio Fipresci 2022 [giuria
composta da: Diego Faraone (Uruguay), Ana Sturm (Slovenia), Andrea Crozzoli
(Italia), Essam Zakarea (Egitto) e Ronald Glasbergen (Olanda)] con la seguente
motivazione: “un’osservazione tenera e
struggente di due anime profondamente ferite, un ritratto di una generazione
ossessionata dai traumi del passato e uno spaccato di vita delizioso e
agrodolce della quotidianità di una coppia di anziani nella Cina contemporanea”.
Un festival, quindi,
complessivamente giovane, vivace, curioso, contaminato, per raccontarci un
mondo in continuo divenire, fluido, ondivago, dove ancora una volta, però, il
cinema si rivela strumento essenziale e attendibile di narrazione,
documentazione e riflessione.