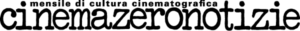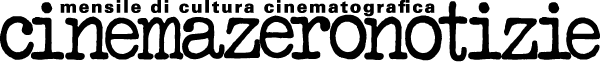Lo chiama(va)no Trinità

di Paolo D’Andrea
Il 2022 è l’anno dei centenari. Su tutti, per ovvi motivi, spiccano quelli di Pier Paolo Pasolini e di Ugo Tognazzi; un poco svantaggiati dalla concorrenza quelli del “nostro” Damiano Damiani – nativo di Pasiano di Pordenone – e di Mauro Bolognini. In verità, un altro classe ’22 si sbraccia dalle retrovie: è quell’Enzo Barboni, alias E.B. Clucher, autore di alcuni dei più amati film della coppia Bud Spencer-Terence Hill, dal seminale Lo chiamavano Trinità (1970) a Non c’è due senza quattro (1984).
In un Paese che ancora fatica a fare i conti col suo cinema popolare, Barboni è spesso e volentieri relegato nel limbo dei registi che a cavallo tra gli anni settanta e ottanta conducono il film di genere nostrano ai suoi esiti più crassi e ridanciani. Se da un lato gli si attribuisce il merito di aver codificato una delle coppie cinematografiche più fortunate e remunerative degli ultimi cinquant’anni [1], dall’altro gli si riconosce tutt’al più un onesto professionismo, un inelegante ma efficiente artigianato. Quest’approccio pregiudiziale, invero e in generale assai limitato e limitante, non solo squalifica una carriera cominciata ben prima dell’exploit degli anni settanta, ma svilisce l’intelligenza e la novità dell’operazione parodica messa in campo con il dittico di Trinità. Con largo anticipo rispetto a Mel Brooks, il cui Mezzogiorno e mezzo di fuoco (Blazing Saddles) uscirà soltanto nel 1974, Barboni realizza la più compiuta e penetrante dissacrazione del western – americano e nostrano – che la storia del cinema ricordi.
Fratello minore di Leonida Barboni – uno dei maggiori “bianconeristi” del dopoguerra, collaboratore storico di Pietro Germi –, Enzo frequenta il set dall’età di vent’anni. Come operatore ha modo di partecipare alla lavorazione di capisaldi della Hollywood sul Tevere quali Vacanze romane (Roman Holiday, 1953) e Ben-Hur (Id., 1959) di William Wyler, oltre a Spartacus (Id., 1960) di Stanley Kubrick. Come direttore della fotografia in proprio, lega il suo nome soprattutto allo spaghetti-western: portano la sua firma due capolavori di Sergio Corbucci, Django (1966) e I crudeli (1967), ma ci permettiamo di segnalare in questa sede anche due gioiellini misconosciuti quali The Bounty Killer (1966) di Eugenio Martin e Un treno per Durango (1968) di Mario Caiano. L’esordio alla regia è segnato dal crepuscolare e tragico – nel senso greco del termine – Ciakmull – L’uomo della vendetta (1970), del quale cura anche la fotografia debitrice delle atmosfere post-apocalittiche di Django: il film sarà tuttavia eclissato dal successo di Lo chiamavano Trinità, uscito nello stesso anno.
Come ha intelligentemente osservato Alberto Pezzotta, Trinità è percorso da uno spirito rabelaisiano: una forma di realismo grottesco in primis, una vena carnascialesca di capovolgimento in secondo luogo. L’incipit parla chiaro: il protagonista non conduce un cavallo, ma è condotto da un cavallo; non si presenta fiero e ieratico, ma sudicio e dormiente. Un’immagine, più di ogni altra, esplicita l’intenzione: quella che inquadra una vacca sul tetto della locanda ove si ristora – abbondantemente – Trinità: è l’inversione del basso con l’alto, autentica cifra del film. Stanco dei body count gargantueschi – a proposito di Rabelais… – del tardo spaghetti-western, Barboni unisce alla dissacrazione un ritorno alle origini in termini di rappresentazione della violenza: certo, qualche morto ammazzato c’è ancora – Bambino, all’inizio, ne stende a revolverate tre in un colpo solo, memore del Joe di Per un pugno di dollari –, ma alla fine tutto si risolve con la logica delle comiche mute: schiaffoni inoffensivi, cadute acrobatiche e distruzione del set tramite oggetti sempre più giganteschi e improbabili. Il tutto ha un che di parrocchiale, inutile negarlo, ma fa ridere grandi e piccini a tutt’oggi: esattamente come i capolavori di Chaplin, Keaton e Stanlio & Ollio.
È stato bello rivedere Lo chiamavano
Trinità in sala, in una versione preziosamente restaurata dalla Cineteca di
Bologna. Raramente ho visto un pubblico tanto eterogeneo: dal bambino di sette
anni al signore di ottanta. Ho sentito i più piccoli esultare agli uppercut invertiti
di Bambino e ridere a crepapelle alle acrobazie di Trinità. Quanti film italiani
con oltre cinquant’anni d’età possono vantarsi di suscitare lo stesso effetto? La
risposta a questa domanda ci ricorda quanto questo film abbia bisogno di
riconoscenza e valutazioni esenti da preconcetti e luoghi comuni.
[1]Codificato e non inventato: l’intuizione delle potenzialità comiche del duo Spencer-Hill va attribuita a Giuseppe Colizzi. Nella trilogia composta da Dio perdona… io no! (1967), I quattro dell’Ave Maria (1968) e La collina degli stivali (1969) i caratteri dei due virano gradatamente verso il comico.