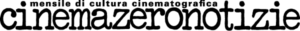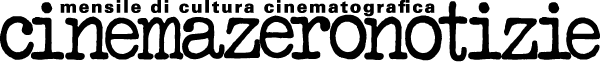Morte a Berlino

Di Marco Fortunato
Parafrasare Luchino Visconti può essere una chiave per provare a tracciare un immaginario fil rouge che ha unito molte delle opere che si sono contese l’Orso d’Oro alla recente Berlinale, conclusasi pochi giorni fa. Una morte, quella vista sul grande schermo a Berlino, intesa sia in senso fisico, come trapasso del corpo con conseguente necessità di elaborazione del lutto da parte di chi resta, ma anche spirituale, o metaforica, spesso generativa di grandi cambiamenti, sia positivi che negativi.

Impossibile non iniziare questo escursus dal film che ha scelto di inserire la parola “morte” fin dal titolo. È quanto ha fatto il regista tedesco Matthias Glasner che con il suo Sterben (che significa morte in tedesco appunto) ha raccolto un ottimo riscontro di pubblico e critica – conquistando anche un meritatissimo l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura – con un sorprendente melodramma che partendo dalle vicissitudini di una famiglia disfunzionale riesce a mettere in scena i tanti aspetti di una vita che finisce. Anzi di più vite perché quello di Glasner è un film corale dove ad essere protagonisti sono soprattutto le relazioni interpersonali tra le persone. L’autore è abile nel sottolineare, pur senza essere didascalico, il rapporto causale che lega il comportamento di un personaggio alla reazione di un altro. Tutto ha inizio nel corso di una riunione di famiglia – il cui pretesto, guarda caso, è il lutto – durante la quale lo spettatore già percepisce un clima mortifero. Ognuno dei commensali ha infatti a che fare, in modi e forme diverse, con la morte. E vi si rapporta in maniera completamente diversa. Attorno al tavolo siedono il padre, affetto da demenza, che si rende conto del progressivo arrivo della “fine” i cui effetti si fanno ogni giorni più manifesti; la madre, perennemente presa dagli impegni e che viene messa di fronte alla sua inadeguatezza rispetto a questo ruolo e all’impegno che esso comporta (un ruolo dunque che essa stessa ha scelto volontariamente di “lasciar morire”) e i due figli, il primo, musicista, che sta componendo un’opera sulla morte in compagnia dell’amico con istinti suicidi e l’altra, vittima dell’alcolismo, che ne ha di fatto già ucciso le relazioni e la voglia di vivere. Anche se può sembrare impossibile con tutto questo materiale, ulteriormente arricchito dalle vicissitudini di altri personaggi, Glasner confeziona un “opera piena di vita”, come ha scritto il Guardian, che si destreggia nel raccontare la complessità della vita vista come antitesi alla morte. Nel farlo l’autore sceglie un’intelligente vena ironica, senza scivolare mai nella commiserazione, sapendo emozionare e coinvolgere il pubblico per tutte le tre ore.

Di morte parla anche Another End di Piero Messina (cui abbiamo dedicato un articolo il mese scorso) che ci porta in un domani sospeso, in un universo misterioso nel quale, grazie ad una tecnologia innovativa, una società è in grado di riportare in vita, per un breve periodo, chi non c’è più, mettendolo nel corpo di un altro essere umano. È a loro che sceglie di affidarsi Sal, il protagonista, che ha perso sua moglie in un tragico incidente. L’obiettivo sarebbe quello di sfruttare questo tempo, che dovrebbe esser molto breve, per dirsi addio ma, com’è lecito immaginare, riconnettere due persone divise dal destino, può avere conseguenze inaspettate. Un’opera seconda molto ambiziosa quella di Messina che nove anni dopo il suo esordio con L’attesa, torna sul tema della separazione, del lutto e delle strategie per elaborare il dolore che ne consegue. Lo fa in un film ricco di citazioni cinefile e di linee narrative (ma con un tema del genere e in un racconto che gioca sul confine tra il reale e l’onirico forse non poteva essere altrimenti) che per questo a volte rischia di perdere unità ma che, unendo melò e sci-fi rimane comunque un interessante esperimento di reinterpretazione dei canoni del genere.
Chi invece ha dovuto tragicamente affrontare la morte senza alcuna consolazione è stata la giovanissima Hilde Coppi la cui storia è al centro di In Liebe, Heure Hilde di Andreas Dresen, che firma un tenero ritratto della giovanissima combattente della resistenza antinazista che viene incarcerata in un lager – e malgrado la gravidanza e la successiva nascita del figlio le permettano di posticipare il suo destino – dovrà affrontare una tragica morte, che sarà prima psicologica e poi fisica. Un contrasto, quello tra sofferenza e dolore che trasudano nell’ambiente del lager, e la felicità della vita in libertà (resa efficacemente da una serie di flashback che ricostruiscono la vita di Hilde nel periodo precedente alla cattura) che trasmette con efficacia la potenza di un messaggio univoco: per quanto tragica, ingiusta e dolorosa anche la morte può essere sconfitta, da solidi ideali e dall’amore. Ed in effetti il riconoscimento dell’enorme sacrificio e dell’impegno contro il nazismo è giunto fino a noi e, anche se sono passati più di ottant’anni dai tragici fatti narrati, il valore di quanto fatto dai membri del gruppo soprannominato “Orchestra Rossa” giunge al pubblico in tutta la sua potenza. Merito, più che della scrittura che appare a volte un po’ troppo didascalica dalla straordinaria interpretazione di Liv Lisa Fries che forse avrebbe meritato di essere premiata.
Ma alla morte si può anche sopravvivere, se a morire non è l’intero corpo ma solo parte di esso. È quanto accade a Edward, il protagonista di A Different Man, il cui sogno sarebbe di poter fare l’attore, obiettivo tutt’altro che semplice essendo il suo volto coperto da malformazioni ed escrescenze ripugnanti che gli rendono quasi impossibili anche azioni semplici, come vedere da un occhio o fischiare. Per questo, oltreché per amore della nuova vicina di casa, Edward deciderà di tentare una cura sperimentale che promette di donargli un volto nuovo. Così accadrà ed Edward si troverà, bello come non mai, a iniziare una nuova (?) vita, potenzialmente ricca di soddisfazioni e felicità. Che però non raggiungerà mai. Grazie alla cura miracolosa, ad essersene andato è solo l’aspetto esteriore di Edward, ma non la sua personalità. Lo capirà molto bene quando il suo ruolo nella nuova piece teatrale cui ambisce verrà preso – ironia della sorte – da Oswald, affetto dalla sua stessa malattia ma con un carattere opposto. Sarcastico, divertente, passionale, talentuoso, Oswald fa il suo ingresso in scena in maniera dirompente conquistando il pubblico (sia quello dello spettacolo messo in scena che quello della sala cinematografica) e dimostrando che il fascino e la bellezza, quella vera, risiede nell’essenza delle persone.

Quelle stesse persone che hanno affollato il festival che, quasi a fare da contraltare ai temi dei film di cui vi abbiamo appena raccontato, restituiscono l’immagine di un festival e di un settore, quello del cinema, più vivo che mai.