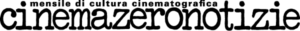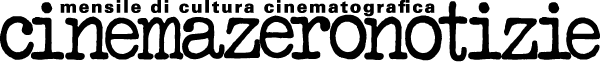Amarcord Sergio Leone

Dove la mano dell’uomo non aveva messo piede …
sentieri di cinema!
Di Andrea Crozzoli
Mi ricordo, sì mi ricordo Sergio Leone al nostro primo incontro quaranta anni or sono, nel marzo del 1984, a Torino. Preparavamo per l’edizione di quell’anno de Le giornate del cinema muto un omaggio a Roberto Roberti, che era non solo il regista preferito di Francesca Bertini ma anche il papà di Sergio Leone (non per nulla all’uscita di Per un pugno di dollari Leone usò lo pseudonimo Bob Robertson ossia letteralmente “Roberto figlio di Roberto”).
Leone si trovava a Torino per un seminario sul suo cinema ospite degli amici del Movie Club, un circolo di cultura cinematografica animato dagli allora giovani cinefili Steve Della Casa, Roberto Turigliatto e Alberto Barbera. Prima di un’abbondante cena piemontese terminata con gli amaretti fritti, Sergio Leone mi concesse un’intervista esclusiva (che fu pubblicata su Il Piccolo di Trieste) accettando volentieri di venire a Pordenone in autunno per vedere i film del padre di cui aveva solo letto. Dopo il nostro incontro, a maggio avrebbe presentato a Cannes il suo ultimo film C’era una volta in America un’opera che lui considerava, come mi dichiarò all’epoca, «intimista, la storia di un perdente, di un’amicizia fallita, della morte. Non c’è violenza, ma suspense.».

Sala del Teatro Verdi per Le giornate del cinema muto 1985 (da sx a dx Malthete Méliès, Jean Mitry, Davide Turconi, Sergio leone e la moglie Carla Leone)
L’anteprima mondiale del film era avvenuta il 17 febbraio 1984 a New York con una versione del film di 269 minuti, ma all’anteprima europea di Cannes avrebbe presentato una seconda versione di soli 229 minuti.
Aveva combattuto dieci anni per realizzarlo a causa soprattutto dei dissapori con il produttore Alberto Grimaldi che abbandonò il progetto, oltre alle sceneggiature fatte e rifatte decine di volte. Una volta varato definitivamente il film, raccontò che impiegò solo «sei mesi di sopralluoghi e altri sei per girare. Abbiamo girato a New York, Montreal, Venezia, in Florida e a Cinecittà gli interni. Più un paio di mesi per il montaggio.». Sulla durata del film seguì poi un’aspra battaglia con la produzione e distribuzione; Leone mi disse che «all’inizio i produttori pensavano di dividerlo in due parti, come Novecento di Bernardo Bertolucci, poi è saltata fuori una legge americana che vieta di immettere nel mercato la seconda parte se non dopo tre mesi dall’uscita della prima. Questo per evitare concorrenze sleali fra distributori. Se la cosa poteva andare bene per Novecento, non va certo per il mio film che deve essere visto tutto di seguito. Al massimo la seconda parte il giorno dopo. Il film è costruito a flashback e l’inizio si ricollega con il finale, che è a sorpresa e chiarisce molte cose. La storia va appunto dal 1922 al 1933, con un salto nel 1968 che apre e chiude. Già mentre giravo ho tolto molte cose previste dalla sceneggiatura, ad esempio quella di un cinemino degli anni venti, dove si proietta un film di Rodolfo Valentino e dove cento donne estasiate e con gli occhi sgranati davanti allo schermo sono prese di mira da un gruppo di ragazzini che approfitta di spogliarle di spille, collane e braccialetti.».
Per Robert De Niro aveva una grande stima e considerazione, «fin dall’inizio – mi disse – avevo pensato a De Niro dopo averlo visto in Mean Street. Un attore favoloso, che ama il proprio lavoro. Ci siamo subito capiti. Puntiglioso, preciso, quasi maniacale. Per un mese si è presentato sul set all’una di notte per farsi truccare da vecchio ed essere pronto a girare alle sette del mattino.». Su Clint Eastwood, che aveva lanciato a livello internazionale con la trilogia del dollaro, invece era caustico, sfoderava tutta la sua sorniona ironia e lo ritraeva come «un tipo magro, con il volto un po’ effemminato, spalle strette, che non parlava mai… Ormai alla fine della carriera, Clint Eastwood si

accontentava della metà della somma richiesta da James Coburn. Gli misi un
poncho per sopperire alla carenza di spalle, la barba lunga di una settimana per indurire il volto e un sigaro perennemente in bocca. Eastwood ha solo due espressioni: una con il cappello e una senza il cappello. Ma per quella parte funzionava a meraviglia.» Già all’epoca, in Francia, Sergio Leone lo chiamavano maestro e lui in maniera sorniona accettava questa corte, cosciente del suo ruolo e del suo talento senza però mai abbandonare quell’autoironia, quella vena bonariamente demistificatoria ma mai cinica. Venne a Pordenone nel 1984 e rimase folgorato dalla manifestazione dedicata al cinema muto. Animo sensibile, dopo aver visto sullo schermo del Teatro Verdi un primo piano della mamma diretta dal padre in un western girato sulle rive del Po, al riaccendersi delle luci in sala si asciugò le lacrime per la commozione. Tornò a Pordenone l’anno seguente, nel 1985, sempre per Le giornate del cinema muto dedicate questa volta a Thomas Ince e al western. Accettò di fermarsi, a fine manifestazione, anche la domenica 6 ottobre 1985 per presenziare all’inaugurazione della nuova sala grande dell’Aula Magna rinnovata da Cinemazero con un nuovo arredo e nuove poltrone, dove proiettavamo in anteprima per la città C’era una volta in America. Eravamo orgogliosi di poter avere in sala Sergio Leone ma anche preoccupati che la qualità tecnica della proiezione fosse all’altezza delle sue aspettative. L’anno prima aveva fatto annullare la proiezione per la stampa alla sala Excelsior della Mostra del Cinema di Venezia giudicandola tecnicamente inadatta al suo film. Fortunatamente da noi tutto filò liscio.
Con la stessa emozione di allora ci prepariamo, quaranta anni dopo, a ritornare in sala per ammirare la copia restaurata del capolavoro C’era una volta in America ricordando con nostalgia che c’era una volta un maestro di nome Sergio Leone.