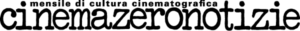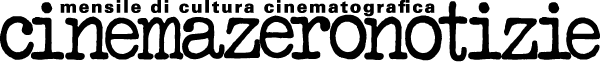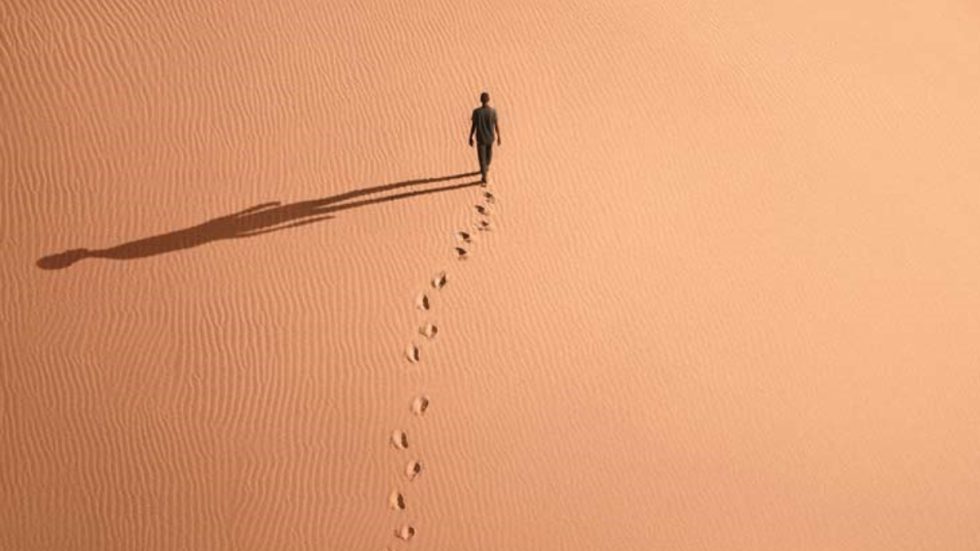Dante Spinotti: l’uomo che filmava il cinema

Dove la mano dell’uomo non aveva messo piede …
sentieri di cinema!
Di Andrea Crozzoli
Dopo una folgorante carriera iniziata oltre quarant’anni fa, per Dante Spinotti è giunta finalmente l’ora dell’attesa autobiografia, scritta con Nicola Lucchi e pubblicata da La nave di Teseo, dal titolo Il sogno del cinema. La mia vita, un film alla volta che verrà presentata, grazie a Cinemazero, in anteprima assoluta all’interno di Pordenonelegge, domenica 17 settembre 2023, alle 17.30, al Capitol di Pordenone in viale Mazzini. Una ghiotta e imperdibile occasione per conoscere e ascoltare dal vivo questo straordinario direttore della fotografia friulano, due volte candidato all’Oscar. Lo incontriamo a Muina, frazione di Ovaro, dove ha le sue radici e dove trascorre ogni anno un periodo di riposo.
Qual’è stato il percorso da Muina a Roma e al cinema?
Un mio zio udinese, Renato Spinotti, che aveva avuto una carriera come documentarista, operatore, direttore della fotografia in giro per il mondo, nel suo peregrinare era finito a Nairobi in Kenia. A me da ragazzo non piaceva il greco e il latino, per non parlare della matematica, della chimica e così via. Così la mia famiglia, disperata, dopo aver finito la prima al liceo classico, visto che l’unica passione che avevo era la fotografia, mi spedì da questo mio zio in Kenia. Da allora la mia vita è sempre stata una vita in movimento. Che è esattamente quello che consiglio ai giovani oggi: mai fermarsi. Ogni estate veniamo a Muina, dove abbiamo la casa di famiglia, un solido punto di riferimento. Sono nato a Tolmezzo, ho vissuto i primi anni in provincia di Rovigo in mezzo alla campagna e ogni estate si veniva a Muina. Poi sono stato sempre in giro. Da giovane ho imparato l’inglese essendo il Kenia un’ex colonia britannica e questo mi è molto servito. Un tempo non era frequente conoscere un’altra lingua e conoscere l’inglese mi ha dato grossi vantaggi. In Rai chiamavano me come assistente ogni volta che c’era un regista o un attore inglese. Oppure, se c’era da fare un giro in America con Enzo Biagi, mandavano me.
Com’è cambiato nel corso del tempo il lavoro della fotografia nel cinema dall’analogico al digitale?
L’arrivo del digitale è stata una vera e propria rivoluzione, paragonabile all’avvento del sonoro nel cinema. Nelle arti, dalla pittura alla musica, puoi fare l’opera e correggerla, modificarla continuamente finché l’artista non è soddisfatto. Nel cinema, invece, quando avevi girato una scena era quella e basta. Vedevi il risultato dopo alcuni giorni, una volta sviluppata la pellicola ma quella era, non potevi cambiarla se non rigirandola. Ora la tecnologia digitale ti permette di vedere il prodotto finito nel momento stesso in cui lo stai facendo e questo ti da una enorme sicurezza nel lavoro. Io ho subito abbracciato questa novità fin dall’inizio. Oggi la tecnologia ha raggiunto una qualità indistinguibile dalla pellicola e il digitale ha cambiato il modo stesso in cui si gira un film. Tutto è molto più semplice e facile. Con il digitale è sufficiente mantenere lo standard ed archiviare nei nuovi supporti mentre la pellicola si degrada rapidamente essendo composta da materiali biologici. Già dopo due settimane la pellicola subisce trasformazioni.
Lei ha lavorato molto sia in Italia che negli Stati Uniti. Quali sono le differenze più eclatanti fra questi due modi di “fare” cinema?
Nel cinema d’oltre oceano c’è una attenzione e una cura quasi maniacale alla sceneggiatura. Il film non parte fintanto che tutti non sono pienamente convinti dell’opera. Il potere del regista, naturalmente, cambia in base alla sua forza. Negli Studios ci sono anche una serie di funzionari che conoscono a fondo il cinema a differenza dell’Italia dove, fatte le debite eccezioni, spesso i produttori sono interessati unicamente al denaro, agli appalti, agli anticipi della Rai. Negli Usa i budget sono molto alti per cui c’è una grande attenzione al piano di lavoro, a mantenere tutti i costi entro le cifre previste. Tutto funziona con grande precisione. Il vantaggio in Italia è che tutto procede come in un gruppo di amici. Una troupe di sessanta persone riesce a stabilire un clima interessante e divertente che è impossibile quando si arriva a ottocento persone coinvolte, come negli Stati Uniti. Insomma in Italia può essere più interessante dal punto di vista creativo, della costruzione delle immagini anche se debbo dire che oltreoceano il cinema indipendente sta prendendo sempre più piede. Io stesso lavoro con Deon Taylor regista indie di grande talento, col quale ho fatto tre film ed un altro è in cantiere. Con i mega budget della serie Marvel significa lavorare ad un film che è già stato girato, tutto è previsto, ogni scena è già stata provata con gli stuntman, le inquadrature strette o larghe già decise a priori e il direttore della fotografia fa semplicemente il consulente, si occupa solo del look. L’unica cosa bella è che in America ti mettono tutto a disposizione, anche ventisei cineprese.
Com’è il rapporto fra regista e direttore della fotografia. Viene coinvolto nella fase di sviluppo del progetto? Partecipa ai sopralluoghi e alle location? Stabilisce subito cosa è possibile e cosa no?
Fra regista e direttore della fotografia molto spesso si stabilisce un rapporto di amicizia oltre che di stretta collaborazione. Un regista come Michael Mann ad esempio vuole controllare tutto, è molto pignolo. I sopralluoghi sono accurati e le ricerche precise in ogni dettaglio. Quando si lavora con un regista che sa esattamente cosa vuole, quale storia vuole raccontare, tutto diventa estremamente semplice.
A 38 anni lei diventa responsabile della direzione della fotografia in Minestrone di Sergio Citti (1981) con Ninetto Davoli, Franco Citti e Roberto Benigni. Che ricordi ha di quel set, di Sergio Citti e degli attori?
Lavoravo alla Rai di Milano e un giorno passò per gli studi televisivi Elio Petri che stava lavorando a Le mani sporche, una miniserie televisiva con Marcello Mastroianni e Anna Maria Gherardi. Aveva sentito parlare di me e segnalò il mio nome a Sergio Citti che stava preparando Minestrone. Fu un set difficilissimo, mi chiamavano il milanese appena arrivai in questo set romanocentrico con la responsabilità della direzione della fotografia. Le riprese furono lunghe e complesse e nonostante le tensioni, frustrazioni, ansie emotive alla fine restammo amici. Sergio Citti era un grande narratore sicuramente, aveva questo istinto nel raccontare le storie che è la chiave di volta di ogni regista: il saper raccontare con gli strumenti del film. Lui aveva questa istintiva capacità.
Ritroverà poi nel 2002 di nuovo Roberto Benigni per Pinocchio. Com’è andata quella sua esperienza?
Pensando che io avessi maturato negli Usa una certa esperienza di film complessi e con molti effetti speciali, Roberto Benigni mi chiamò a curare la fotografia di Pinocchio. Mi ritengo molto fortunato ad aver lavorato con lui, Benigni è un personaggio non trasformabile, nel senso che la sua umanità, la sua cultura lo rendono unico. L’errore che commise è stato quello di voler fare un film molto vicino al testo di Collodi. Ma il film è una cosa molto diversa da un libro e il testo collodiano, oltretutto, è anche piuttosto datato. Fu molto bello però girarlo. Rientrato in America al termine delle riprese incontrai Dino De Laurentis che mi chiese se il film faceva ridere e davanti alle mie perplessità sentenziò: «Se non fa ridere non funziona!». E così fu. Soprattutto fuori dell’Italia.
La metà degli anni ottanta corrisponde anche con la sua prima esperienza totalmente hollywoodiana. Entra nel cinema americano dalla porta principale con Manhunter di Michael Mann (1986) prodotto da Dino De Laurentis. Com’è avvenuto l’incontro con De Laurentis?
Devo a De Laurentis se ho fatto quello che ho fatto. Mi ricevette nel suo ufficio all’ultimo piano di quella che oggi si chiama Trump Tower. Uno studio enorme seduto dietro questa grande scrivania. Aveva fondato in North Carolina uno studio cinematografico e cercava direttori della fotografia che non fossero statunitensi. Gli piaceva il fatto che io conoscessi l’inglese e firmai con lui un contratto biennale. Persona squisita, leale, corretta. Aveva una capacità incredibile di prendere decisioni da cui poi non tornava più indietro. Aveva anche una forza molto determinata di rigenerarsi, di ricominciare da capo. Si occupava di tutti gli aspetti legati alla produzione dei suoi film. A distanza di sedici anni da Manhunter mi chiamò per la fotografia del remake Red Dragon di Brett Ratner (2002), dove questa volta Hannibal Lecter, diversamente dal precedente, aveva la faccia di Anthony Hopkins. Un film all star con Ralph Fiennes, Edward Norton, Harvey Keitel e Emily Watson e prequel del pluripremiato Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme.
Ancora per Dino De Laurentis nel 1986 ha avuto la direzione della fotografia in Crimini del cuore (Crimes of the Heart) di Bruce Bereford con un cast tutto al femminile: Sissy Space, Diane Keaton, Jessica Lange. Com’è il rapporto fra diva e direttore della fotografia?
Portai a De Laurentis una scena di Interno berlinese che a lui piacque talmente per cui decise che avrei curato la fotografia del film di Bereford. Tre attrici bravissime, tre professioniste spiritose. Per una scena in cui le tre attrici discutono attorno ad un tavolo dovevo illuminare i tre diversi primi piani cercando di non far trasparire che ognuna di esse era illuminata per conto proprio ma che ci fosse un’omogeneità fra loro tre. Il risultato fu che da allora mi venne affibbiata la nomea di essere un direttore della fotografia che toglieva dieci anni alle attrici.
Grazie a De Laurentis conosce dunque Michael Mann che è unanimemente considerato uno dei migliori registi di Hollywood. Con lui stabilisce un raro (per il mondo del cinema) sodalizio, lungo e proficuo. Cosa vi unisce, come lavorate assieme?
De Laurentis mi ha catapultato in un cinema di assoluta disciplina, di assoluto rigore. Mann lasciava all’aiuto regista gridare, tenere il set. Lui controllava tutto ed aveva un rapporto totale con gli attori. Un rapporto anche difficile alcune volte. Michael Mann, se vogliamo, è una specie di dottor Jekyll e mister Hyde. Sul set si trasforma mentre sulla vita normale è molto più colloquiale. Quando si gira un film deve avere il controllo totale del set. Con Mann forse è scattato quel qualcosa per cui istintivamente sentivo il suo modo di girare come mio. Aveva fatto emergere qualcosa in me di inespresso fino a quel momento. Fare un film con Michael Mann è una vera e propria sfida con sé stessi e con le proprie possibilità. Capire quello che lui ha in mente non è da tutti. Ogni film fatto con lui è una totale immersione sul mondo che viene affrontato di volta in volta.
In L’ultimo dei Mohicani (The Last of the Mohicans) ha lavorato con Daniel Day-Lewis famoso per la sua intransigente pignoleria. Il film ebbe anche lusinghieri apprezzamenti per la fotografia. Come è stato lavorare con Day-Lewis?
Daniel Day-Lewis è stato un compagno di lavoro straordinario, L’ultimo dei Mohicani era il suo primo impegno importante negli Stati Uniti. Lui è di una preparazione che rasenta il maniacale. Su ogni dettaglio di sceneggiatura annotava e si preparava con caparbietà. Si allenava per sparare col fucile correndo. Tutte cose inimmaginabili in un attore italiano.
Per la direzione della fotografia lei ha avuto la nomination agli Oscar con L.A. Confidential, regia di Curtis Hanson (1997) dove per questo film vinse l’Oscar Kim Basinger come miglior attrice non protagonista …
Los Angeles è bella da fotografare oggi e ancor più affascinante vestita da anni ‘40/’50. Ho usato un formato super 35 anziché lo scope per avvicinarmi il più possibile al formato delle foto d’epoca di Robert Louis Frank. Col regista Hanson è stato interessante lavorare in quanto ricercava un’aderenza quasi filologica al racconto. Con l’affascinante Kim Basinger solo nelle ultime due scene ho capito come avrei esattamente dovuto fotografarla. Nonostante questo, però, vinse l’Oscar con L.A. Confidential.
Nel contempo lei ha tenuto anche un fruttuoso rapporto col cinema italiano. Due film con Ermanno Olmi, La leggenda del santo bevitore (1988) Leone d’Oro a Venezia oltre al David di Donatello e Ciak d’Oro per la miglior fotografia a Dante Spinotti e Il segreto del bosco vecchio (1993)…
Ho conosciuto Ermanno Olmi da ragazzino. Sono stato suo assistente per il film E venne un uomo in quanto segnalato da Mario Rigoni Stern, che era molto amico di Olmi, e che a sua volta era cugino di mio cognato. Passammo due, tre settimane filmando seminaristi in giro per la bergamasca poi io partii militare e non portai a termine la collaborazione. Molti anni dopo Olmi mi contattò per girare un film a Parigi con Rutger Hauer, La leggenda del santo bevitore appunto. Esperienza bellissima. Mi chiamò poi per girare un film a Cortina Il segreto del bosco vecchio ma qualcosa non funzionò come doveva, la lavorazione non fu così entusiasmante come quella parigina.
Nel 1995 lavora alla fotografia di Pronti a morire (The Quick and the Dead) regia dell’adrenalinico Sam Raimi appena uscito dalla trilogia horror sulla casa. Un film che annovera un cast inimmaginabile oggi con star come Sharon Stone, Leonardo Di Caprio, Russell Crowe e Gene Hackman appunto. Un western che vuole rendere omaggio a Sergio Leone…
Con Sam Raimi abbiamo avuto un rapporto eccezionale. È un regista che costruisce i suoi film su storyboard molto precisi, come i fratelli Coen. Per questo omaggio al western italiano ci divertimmo moltissimo a girare i celebri primissimi piani alla Sergio Leone. La costumista Judianna Makosky venne a Roma in cerca dei costumi originali, questi impermeabili lunghi. Raimi voleva dare al film una valenza quasi paradossale, anche caricaturale, estremizzando le situazioni ma si scontrò con Sharon Stone che era anche produttrice del film. Sam Raimi non aveva ancora la forza che ha acquisito ora, dopo aver diretto i tre Spiderman. La Stone, donna simpaticissima oltre che bellissima, voleva però intervenire sulla lavorazione forte della sua posizione di produttrice. Sharon Stone si rifiutò di girare una scena con Russell Crowe in cui lei, a seno nudo, faceva gonfiare la patta di Crowe fino a far letteralmente saltare i bottoni. Un po’ alla volta il senso complessivo del film venne stravolto. Ogni paradosso annullato tanto che alla fine risultò, purtroppo, né carne né pesce.
Nel 1995 firma anche la fotografia di L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore con Sergio Castellitto. Com’è stato passare da Sam Raimi a Tornatore, ma anche da Leonardo Di Caprio a Sergio Castellitto …
Sono salti grossi. Con Tornatore non ci siamo parlati per almeno tre quarti del film. Ognuno cercava di far vedere di essere più bravo dell’altro. Mettiamo la macchina da presa lì e non là, etc. Un friulano e un siciliano a confronto! Poi alla fine siamo diventati amicissimi. Tornatore è un grande talento, un notevole narratore. Castellitto poi mi aveva chiamato per fare un film con lui ma precedenti miei impegni mi hanno impedito la nuova collaborazione.
Lei ha lavorato nel 1996 anche con un altro mito americano che è Barbra Streisand in L’amore ha due facce (The Mirror Has Two Faces). Come è stata l’esperienza di avere la Streisand davanti e dietro la macchina da presa nel duplice ruolo di attrice e regista?
Con Barbra Streisand il vero problema era averla davanti la macchina da presa non tanto dietro la macchina come regista. Persona amabile, democratica, la sera si andava a casa sua a mangiare il gelato a discutere ma sul set era un dramma, decine di prove, di dubbi, di complicazioni e con la scusa del Natale, l’unica volta in vita mia, sono andato via dal set.
Ha mai rinunciato a un film per poi pentirsi?
Sì, fra i tanti anche la proposta di Sam Raimi di fare il primo Spiderman!
C’è un regista col quale non ha mai lavorato ma per il quale avrebbe voluto curare la fotografia in un film?
Avrei io dato qualsiasi cosa per fare un film con Kubrick pur sapendo della sua estrema pignoleria e precisione. Una volta, rientrando dagli Stati Uniti, mi dissero che Federico Fellini mi aveva cercato per un film. Purtroppo subito dopo si ammalò e il film non prese più il via. Fellini aveva la fama di essere un regista costoso per come girava, come costruiva i set, con i tempi che si allungavano e i budget che sforavano. Ma era un genio.