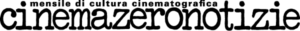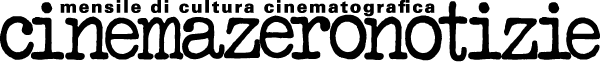Il cinema fa scuola: in Mediateca!

Crescono il numero dei prestiti, le matinée in sala e le attività didattiche nelle scuole
Di Elena Chiara D’Incà
I film ci parlano, ci narrano una storia, ci emozionano, ci coinvolgono, ma allo stesso tempo, dall’analisi delle opere filmiche possiamo scoprire molto sulla nostra epoca e su quelle passate, sui modelli culturali interpretativi della realtà: ogni film infatti è il risultato di un punto di vista unico e personale – quello del suo regista.
Vedere un film può rappresentare un ottimo strumento di analisi della realtà nella sua complessità di sfaccettature ma anche di rilettura storica, culturale, artistica delle epoche passate.
Il cinema quindi diventa un prezioso strumento di formazione, non solo nell’approccio alle materie curricolari, ma anche come base per un approfondimento, un ampliamento, uno stimolo a riflessioni più profonde sia in ambito scolastico che extra-scolastico.

Formare al cinema di qualità, formare con e attraverso il cinema sono degli obiettivi che la Mediateca di Cinemazero persegue da anni e questo ruolo è riconosciuto ed apprezzato da quanti utilizzano i patrimoni ed i servizi della Mediateca.
Infatti i dati di bilancio di un anno, quello appena trascorso, di attività della Mediateca intesa come attività istituzionale di accesso ai patrimoni e come attività formativa e didattica nelle scuole, testimoniano un continuo incremento rispetto all’anno precedente.
Sfiora quota novemila il numero di film presi in prestito in Mediateca, con un incremento del 20% rispetto al 2021. I titoli più gettonati sono stati: “Parasite” del sudcoreano Joon-ho Bong, “Kiki Consegne a domicilio”, film d’animazione del maestro giapponese Hayao Miyazaki, e “The Lighthouse” di Robert Eggers.
Crescono del 12% anche il numero di utenti che frequentano i servizi della Mediateca. Il dato di frequentazione della mediateca inoltre è il più alto rispetto alle altre mediateche del Sistema, confermandola come la mediateca più frequentata in Regione.

La Mediateca di Cinemazero ha lavorato negli anni per consolidare il suo ruolo di rilievo nel panorama cittadino come punto di riferimento culturale unico ed originale, un luogo nel quale la qualità dei patrimoni e delle offerte culturali attraggono un pubblico eterogeneo, un luogo aperto all’accoglienza e all’inclusione sociale un luogo simbolo della formazione ed educazione all’uso consapevole dei nuovi media e del linguaggio cinematografico e multimediale, un punto di incontro accogliente ed aperto, un servizio di qualità riconosciuto a livello regionale e nazionale.
Non solo un archivio dove trovare un immenso patrimonio di film e libri dedicati alla settima arte, molte sono le attività che la mediateca dedica alla formazione ed educazione al cinema di qualità. Da decenni la mediateca è impegnata nell’attività didattica nelle scuole ed anche questo settore durante l’anno 2022 ha riscontrato un trend positivo:
Ha superato 2.300 il numero di giovani coinvolti nelle decine di proiezioni mattutine di film dedicate agli studenti, a Cinemazero e allo Zancanaro di Sacile, per circa cento classi provenienti da scuole di ogni ordine e grado. Dai più piccoli dell’infanzia ai ragazzi che si stanno preparando per la maturità: il cinema ha offerto proposte adatte agli spettatori di ogni età. Guardare un film in sala, accompagnando la visione a un’introduzione critica, dall’autunno ritorna a essere un’abitudine, di cui è riconosciuta anche la valenza didattica.
Continuano a crescere anche il numero di ore di attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio: oltre 150 ore di didattica del cinema e dell’audiovisivo, realizzata nel corso dell’anno 2022 dagli esperti formatori della Mediateca di Cinemazero, che hanno affiancato i docenti curricolari nell’approccio didattico con e attraverso l’audiovisivo.
La Mediateca di Cinemazero si conferma un servizio ricco ed apprezzato, prezioso per il territorio e in grado di ritagliarsi nel tempo uno spazio di rilievo tra le numerose realtà e attività culturali della nostra città e non solo.