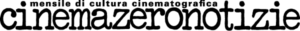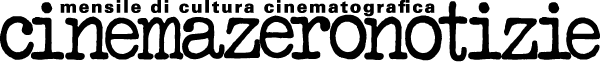GLI ULTIMI GIORNI A KABUL: CRONACA DI UNA SCONFITTA

Di Francesca Mannocchi Foto di Alessio Romenzi
Vincitori del premio IL CORAGGIO DELLE IMMAGINI 2021- Pordenone Docs Fest / Le voci dell’
Il giorno prima che i
talebani entrassero a Kabul, la fila davanti all’ambasciata iraniana nelle
prime ore del mattino era lunga centinaia di metri. L’Ambasciata turca aveva
già sospeso il rilascio di nuovi visti, così come le ambasciate pakistana,
tagika e uzbeka. C’erano file davanti alle banche, gente ansiosa di ritirare i
propri risparmi. Era l’aspetto che assumono le città quando la guerra è vicina:
la paura. E l’istinto di fuga.
Molto prima che il
presidente Ashraf Ghani lasciasse Kabul, su un volo con (secondo Reuters)
valigie con milioni di dollari, circolavano voci sulla sua fuga. Le voci erano
talmente tante che poche ore prima che i talebani entrassero in città, l’ormai
ex presidente aveva registrato un video alla nazione per promettere di unire le
forze armate e le milizie di resistenza e invitare tutti a combattere il
nemico. Molte parole poca sostanza. Quel video, a due settimane di distanza,
era piu’ un modo per dire che non era ancora fuggito, mostrarsi nel palazzo
presidenziale, che una convinta e sicura strategia militare e politica. Purtroppo
il minuto che avrebbe dovuto rassicurare il paese e indebolire il nemico, non
ha sortito l’effetto desiderato. I talebani erano in città meno di tre giorni
dopo.
“…Devo portarli via…”
Qarib ha 30 anni, una
moglie e due figli piccoli. Un buon lavoro, anche. E dall’Afghanistan non
vorrebbe uscire, c’è la sua vita, la sua comunità, i suoi risparmi tutti
investiti in una bottega e in una casa. Non avrebbe voluto scappare, ma era in
fila all’ufficio passaporti a Kabul, il giorno prima che la città cadesse.
Arrivavano già notizie straziate dai parenti lontani, dai familiari che
vivevano sotto le aree controllate dai talebani già da qualche settimana: donne
segregate, scuole chiuse. Collaboratori degli americani trucidati. Attivisti
scomparsi. Sua moglie per due anni aveva lavorato come traduttrice per una
organizzazione umanitaria internazionale, e Qarib, oggi, pensa che anche lei
sia in pericolo. Che rischi di finire come troppe donne, attiviste, freddate in
questi anni. Punite per essersi esposte. “Devo portarli via, lei e i miei figli
– dice – non mi perdonerei se le accadesse qualcosa.”Aveva ricevuto una
telefonata, Qarib, mentre parlava con noi. Dopo aver chiuso la comunicazione
aveva detto: “E’ caduta Maidan Sharh, ormai è questione di ore”.
Maidan Shahr è la
capitale della provincia di Wardak, l’ultima porta prima di Kabul. “Non è piu’
questione di se, è solo una questione di quando”, aveva detto Qarib. Una
profezia “Non sarà difficile entrare per i talebani – aveva concluso – perché
hanno bisogno delle truppe occidentali e contemporaneamente non ne possono
piu’. Ma ora sta vincendo il secondo sentimento: non ne possono piuì di voi.”
Anche noi avevamo respirato la medesima sensazione pochi giorni prima e proprio
a Maidan Sharh, porta di Kabul. Porta fortificata della capitale.
Avevamo assistito ai
funerali di due soldati uccisi in un agguato notturno dei talebani. Le due bare
erano disposte in una stanza adiacente alla base delle forze speciali
dell’esercito afghano. Circa 50 uomini pregavano in ginocchio. La vista di due
occidentali giunti in Afghanistan per raccontare le conseguenze del ritiro
delle truppe statunitensi ha suscitato una palese ostilità tra gli afgani: “Ci
avete invaso, ci avete illuso con la vostra libertà e poi ve ne siete andati. E
ora avete ripreso a bombardarci con i vostri B-52. Andate via, non siete più i
benvenuti», ci aveva gridato un uomo in fondo alla stanza. Gli altri, prima
silenziosi si erano uniti al coro di “andate via”.
Era vero. Gli americani
avevano ricominciato a bombardare le posizioni talebane con i B52. Spiegare
agli afgani quale fosse il senso di quei bombardamenti mentre i talebani si
prendevano il paese non era possibile. Non capivano loro, non capivamo noi. Ma
ci era chiaro, camminando nel paese, che Kabul era questione di ore, non di
mesi come sosteneva il Pentagono.
Il 14 agosto Maidan
Shahr è caduta. Il governatore, che fino a poche ore prima si mostrava tronfio
e battagliero, pronto a riunire le truppe contro il nemico, fuggito coi suoi
uomini, in salvo. Mentre Kabul si preparava alla sua notte peggiore, era chiaro
che il paese stesse per dividersi tra chi poteva garantirsi un’uscita in
sicurezza dal paese e chi era destinato a fare i conti con nuovo futuro, quello
in mano ai talebani.
Non c’è via d’uscita e
non c’è nessun posto dove andare, non c’è un posto sicuro in Afghanistan. Sono
le frasi che piu’ abbiamo ascoltato in quasi venti giorni di Afghanistan.
La notte di paura
La notte del 15 agosto
Kabul è scoppiata di rumore e paura.
Il rumore era quello del
ponte aereo che spostava i dipendenti dell’ambasciata americana verso
l’aeroporto. La paura quella dei cittadini di Kabul che apprendevano le notizie
dalla tv e dai social media: i talebani sono a 12 km, i talebani hanno
assaltato la prigione liberando i prigionieri, i talebani occupano i distretti
di polizia. I talebani hanno la citta’.
Tanto piu’ si faceva
alto il rumore delle evacuazioni, tanto piu’ gli afgani si riversavano
all’aeroporto. L’occidente era in fuga e i Talebani, ormai vittoriosi, mettevano
in scena la loro versione presentabile. Nella sua prima comunicazione pubblica
dopo la caduta di Kabul, persino il mullah Abdul Ghani Baradar, il nuovo
presidente ad interim, ha assunto un tono decisamente non ostile. “Abbiamo
raggiunto una vittoria che non ci aspettavamo”, ha detto in un messaggio
ai talebani. “Dobbiamo mostrare umiltà davanti ad Allah. … ora è il momento dei
test: ora si tratta di come serviamo e proteggiamo le nostre persone e
assicuriamo loro una buona vita al meglio delle nostre capacità”. Ma queste
comunicazioni, che ormai vanno avanti da giorni, sembrano rivolte non tanto ai
cittadini afgani quanto alle potenze straniere. Quelli che non corrono rischi,
che se ne stanno andando. E che hanno tempo per andarsene fino al 31 di agosto.
Le ambasciate occidentali si sono affrettate a evacuare i propri cittadini,
compresi gli operatori umanitari internazionali, aggravando i problemi per gli
afgani. La grande popolazione di sfollati interni dovrà ora fare a meno
degli aiuti esteri e dell’illusione di libertà cui aveva creduto per
vent’anni.
È caduta Kabul e insieme
a lei è caduto il governo Ghani, corrotto, imposto, delegittimato, non amato. È
caduta Kabul e sono già in fuga tutti i signori della guerra che fino a pochi
giorni fa giuravano di versare fino all’ultima goccia di sangue per difendere
il paese dalla furia oscurantista. Oggi osservano quella furia impadronirsi del
paese dal comodo, temporaneo esilio. Qualcuno resterà via, qualcuno tratterà
con il nemico. Cade Kabul e l’Afghanistan perde i suoi uomini e le sue donne
migliori, evacuate, tratte in salvo. Nel paese, troppo umili, troppo ordinari,
troppo poco esposti restano milioni di cittadini, con una moneta in caduta
libera, un’economia che dipende dagli aiuti internazionali, e metà del paese
che vive in uno stato di bisogno. Restano lì, come il nostro traduttore,
collega, amico, che non abbiamo fatto in tempo ad abbracciare. Bevevamo te’,
insieme, poche ore prima che ci evacuassero.
Non abbiamo fatto in
tempo a salutarci. “Sarà per la prossima volta”, ci siamo detti al telefono in
questi giorni. Mentre noi eravamo al sicuro, e lui nascosto in casa per paura
di ritorsioni, perché ha lavorato come traduttore e autista per i giornali
internazionali.
“La prossima volta”, ho
risposto io, scaramanticamente.
Il giorno del nostro
arrivo a Kabul, mentre ci accompagnava in hotel, in quella che sarebbe
diventata la nostra dimora blindata e protetta per qualche settimana ci aveva
detto: questa è la differenza tra noi e voi. Voi potete proteggervi, noi no.
Oggi è quanto mai vera.
Noi siamo potuti andare via, lui e altri milioni di afgani no.