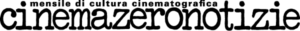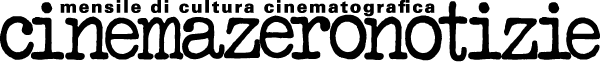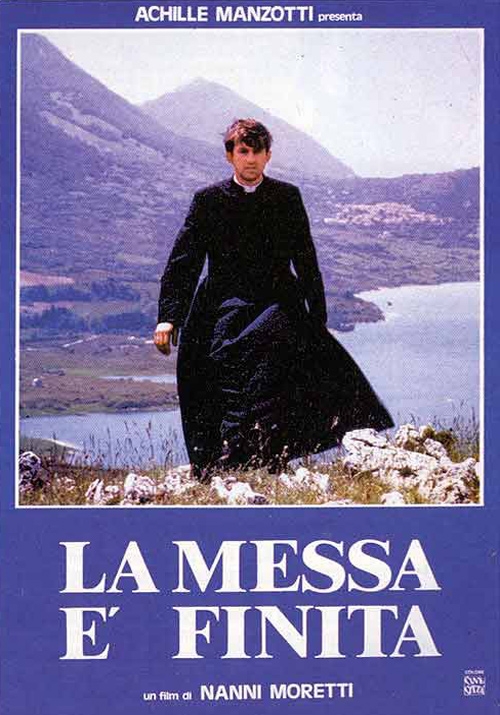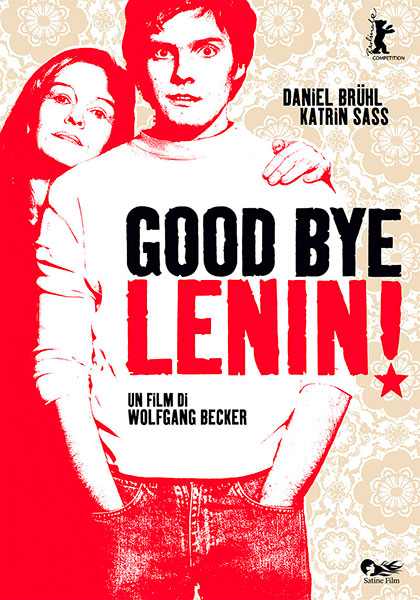PERCHÉ I FILM SONO SEMPRE PIÙ LUNGHI?

Di Marco Fortunato
In questi giorni a Cinemazero sono in programmazione, tra gli altri, l’ultima fatica di Martin Scorsese Killers of the flower moon (tre ore e 26 minuti) e la Palma d’Oro, Anatomia di una caduta di Justine Triet (due ore e trentasei minuti), che seguono di poche settimane l’applauditissimo Oppenheimer di Christopher Nolan (tre ore). Tre opere accomunate dal minutaggio importante che hanno riaperto il dibattito, peraltro ciclico, sulla lunghezza dei film.
In generale l’impressione è che negli ultimi anni quest’ultima sia aumentata notevolmente. Non solo quella dei grandi film d’autore ma anche quelli delle opere più popolari, in particolare le commedie, che fino a pochi anni fa di solito si aggiravano sui 90 minuti. Precisiamolo subito a scanso di equivoci: di film lunghi è ricca la storia del cinema, ciò che in questa sede ci interessa è analizzare il mercato nel suo insieme per capire se possa essere individuata o meno una tendenza e quali possano esserne le motivazioni. Ma partiamo dai dati.
Un interessante articolo apparso sull’Economist pochi giorni fa ha analizzato oltre 100 mila film dagli anni Trenta, quando il sonoro ha stabilizzato la durata dei film, fino ai giorni nostri, evidenziando come la durata media dei lungometraggi sia passata da un’ora e 21 minuti del 1930 ad una di un’ora e 47 del 2022, con una crescita del 24%. Proviamo ad analizzare quali possono essere le ragioni di questa evoluzione.
Premesso che non si è trattato di una crescita lineare, i numeri raccontano che la durata dei film tra gli anni ‘30 e ‘70 si aggirava in media sui 90 minuti. Una delle ragioni di questa stabilità era da ricercare nella pressione coordinata di produttori ed esercenti entrambi propensi a limitare la durata dei lungometraggi. Va considerato che, nell’era della pellicola, la materia prima – ovvero la celluloide – era una voce molto importante e costosa del budget, per cui fare un film più corto significava utilizzarne di meno e dunque risparmiare. Anche gli esercenti dei cinema, per motivi diversi ma pur sempre di natura economica, vedevano di cattivo occhio le opere eccessivamente lunghe. Per essi, infatti, valeva l’equazione che tanto più il film è breve, tanto maggiore è il numero di spettacoli che si possono programmare e di conseguenza di biglietti che, potenzialmente, si possono staccare. E dunque anche loro erano interessati ad una sorta di moral suasion per contenere l’estro creativo degli autori.
Una svolta si ebbe con l’avvento della televisione e il conseguente desiderio dell’arte cinematografica di distinguersi da quella televisiva, anche – ma non solo – per la grandiosità del racconto. Tra i primi anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta (con Lawrence d’Arabia nel 1962 che sfondò la soglia delle tre e mezza quindi con Cleopatra, l’anno successivo,la cui durata iniziale avrebbe dovuto essere di oltre quattro ore per poi essere ridotta, fino a Il padrino nel 1972 con due ore e 55 minuti passando per 2001 Odissea nello spazio con le sue due ore e mezza) la durata media dei film inizio ad aumentare, anche in maniera discontinua. Anche negli anni successivi non mancarono i kolossal del minutaggio, come ad esempio Novecento di Bertolucci, anch’esso costretto a dividere il film che, insieme, superava le cinque ore, o C’era una volta in America di Sergio Leone (162 minuti), ma senza che ciò riuscisse a determinare una tendenza stabile ed univoca.

La vera rivoluzione coincise con l’avvento del digitale che abbatté drasticamente i costi di lavorazione. Quando i dischi rigidi sostituirono la pellicola vennero meno le ragioni economiche che i produttori avevano utilizzato per limitare la creatività degli autori. Anzi la situazione quasi si ribaltò poiché, una volta messo in piedi il set (e pagato il cachet di maestranze ed attori) era conveniente sfruttarli al massimo e, nel dubbio, girare una scena in più – a set allestito – poteva essere una buona idea.
In questi anni presero ad affermarsi le saghe, o film a episodi, a partire da Il signore degli anelli i cui eccezionali incassi dimostrarono che il pubblico non aveva nulla contro i film lunghi e anzi, se la trama lo appassiona, considera la durata una virtù, specie se la sceneggiatura è tratta da un romanzo, quasi che la lunghezza del film fosse associata al riconoscimento ed al rispetto per il racconto originale.
Sulla scorta di questo successo la maggior parte dei film “ad episodi” dagli anni Duemila in poi hanno avuto durate considerevoli. Due ore e ventitré minuti per I pirati dei Caraibi nel 2001 (che fu un successo enorme); Harry Potter e la pietra filosofale (il primo film, del 2002), due ore e trentadue; Guerre stellari episodio VI nel 2005, due ore e venti. E poi ancora I pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma nel 2006, due ore e trenta; Avatar, due ore e quarantadue; Il cavaliere oscuro, due ore trenta; addirittura Martin Scorsese è arrivato a tre ore per The Wolf Of Wall Street e i film di 007 con Daniel Craig sono tutti oltre le due ore venti.
In questi ultimi anni questa tendenza si è ulteriormente consolidata. Basti pensare alla saga degli Avengers (i cui capitoli sono quasi tutti tra le due ore e mezza e le tre) ma anche a film d’autore come Babylon, Avatar 2, The Irishman e al recentissimo Oppenheimer, oltre ai due film citati in apertura.

Le ragioni di questo consolidamento potrebbero essere di due tipi ed in qualche modo rappresentare un’evoluzione dei due motivi che hanno originato questo processo, entrambi a loro volta evolutisi a seguito dell’ingresso sul mercato dei nuovi attori del settore: le piattaforme di streaming. Da un lato infatti il loro ruolo, sempre maggiore, come produttori ha fatto venire meno qualsiasi ostacolo di natura economica. Queste realtà, spesso con grandi società di capitali alle spalle, hanno infatti investito budget senza precedenti e spesso proprio questa disponibilità di risorse – quasi assoluta – è stata utilizzata come leva per attrarre i grandi autori contemporanei (pensiamo a Scorsese ma anche a Cuaron o altri cineasti che hanno pubblicamente dichiarato di aver accettato l’offerta dei colossi dello streaming perché essi garantivano loro totale libertà creativa e, a differenza dei produttori tradizionali, non ponevano nessun vincolo di budget). Dall’altra proprio l’affermazione di nuovi contenuti audiovisivi, come le serie televisive rese popolari dalle piattaforme, ha cambiato i meccanismi di narrazione, spingendo gli autori a un cambio di prospettiva nella costruzione del film. Con un duplice effetto. Da una parte si registra una maggior inclinazione ad approfondire i singoli personaggi del racconto, anche quelli secondari, mutuando uno stratagemma tipico dei racconti seriali che, basandosi sugli indici di ascolto delle singole puntate – o in questo caso della visione dell’episodio della saga – in cui è più o meno presente un determinato personaggio cercano di capire il suo appeal sul pubblico e di conseguenza adeguarne la presenza, riducendone o aumentandone il minutaggio. In un film ciò significa impostare su un personaggio un sequel. Dall’altra la tendenza è ad esaltare le potenzialità visive e sonore del mezzo cinematografico lasciando spazio a dei virtuosismi visivi e sonori, non sempre necessari al racconto, ma funzionali a dare al pubblico l’impressione di assistere a qualcosa di unico e di non replicabile in un’esperienza casalinga – pensiamo all’utilizzo di alcuni effetti speciali o all’ampio uso di droni – quasi a voler esibire la grandezza dell’operazione (e la capacità tecnica del suo autore) e giustificare che la visione di quel film “meriti la sala”.
Ma davvero quello che vuole il pubblico è solo vedere film più lunghi? Spesso l’impressione degli spettatori va nella direzione opposta e non è raro ascoltare o leggere dei commenti a un film che una maggiore sintesi avrebbe giovato all’efficacia della narrazione. A questo proposito, a Natale, arriva sul grande schermo un film decisamente in controtendenza: Fallen leaves di Aki Kaurismäki, un’emozionante commedia sull’amore, essenziale e minimalista nella messa in scena, che dura solamente 81 minuti. Troppo poco per meritare la sala? Al pubblico l’ardua sentenza.