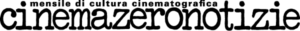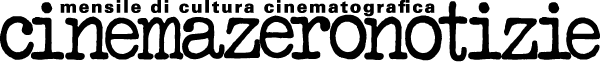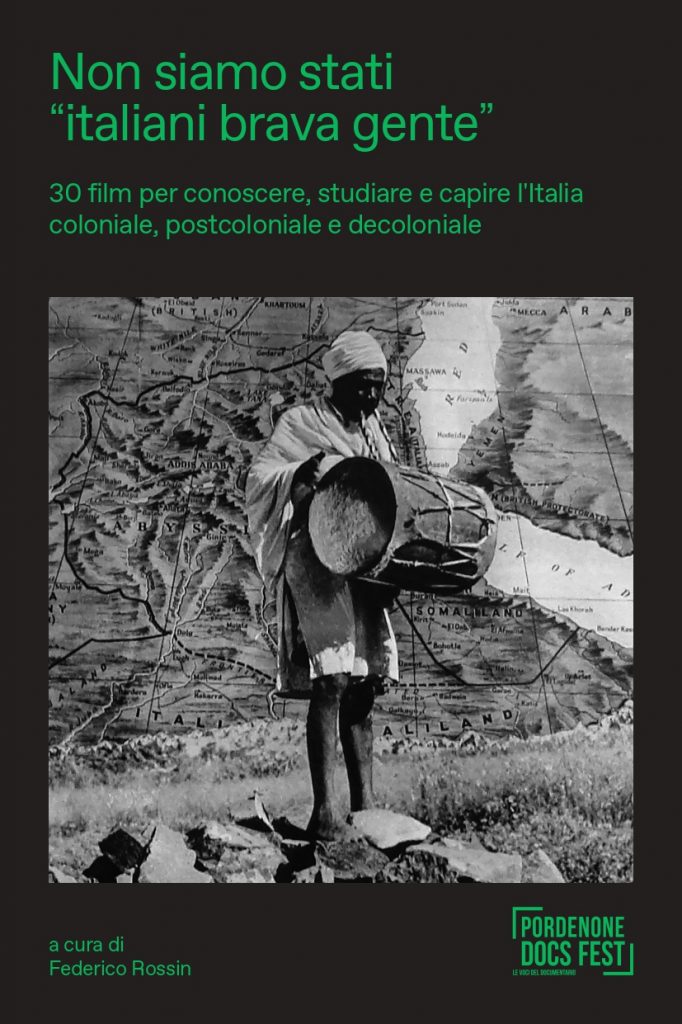L’eterno servo di Joseph Losey

di Paolo A. D’Andrea
Tarda primavera del 2004. Secondo anno delle medie. È ancora l’era di MTV: tenersi aggiornati sulle ultime uscite discografiche significa sedersi in poltrona, di fronte a un televisore, e ascoltare e guardare assieme, strascicati dal susseguirsi di immagine acustiche di un videoclip. Un brano inglese tiene banco. A un adolescente, ben più che armonia e melodia, rimangono impresse le movenze sincopate di chi lo canta. Si chiama Dan Black, è il front man. Il singolo, Liquefy. La band, The Servant.
Ho scoperto così Il servo di Joseph Losey, a tredici anni. Black aveva scelto quel nome con l’intenzione dichiarata di omaggiare il suo film preferito. I The Servant, purtroppo, si dileguarono di lì a breve: meteore. Il dimenticatoio è un posto affollato; ivi convivono l’alto e il basso. Losey, da questo punto di vista, è un loro compaesano. Il dimenticatoio di qualcuno, tuttavia, è molto spesso l’immaginario di qualcun altro – e per fortuna: appassionati, critici e studiosi il regista del Ragazzo dai capelli verdi non l’hanno scordato, anzi. Mentre scrivo, ho sotto gli occhi Senza re, senza patria: il cinema di Joseph Losey, un saggio curato da Luciano De Giusti ed edito da Cinemazero, esito cartaceo di una memorabile edizione dello Sguardo dei maestri. Mentre scrivo, ripenso a quanto è stato bello rivederlo, Il servo, su grande schermo, restaurato, lo scorso 16 maggio in sala Totò, nel contesto di un’iniziativa che proprio dallo Sguardo dei maestri riprende il nome e – in piccolo, umilmente – l’eredità.
Joseph Losey nasce nel 1909 a La Crosse, Wisconsin. All’High School locale, condivide la classe con Nicholas Ray. All’università, dapprima tenta la strada della medicina; il vento della sua passione più grande – il teatro – lo condurrà tuttavia, di lì a breve, verso altri lidi. Negli anni Trenta, talento precoce, è già una figura di spicco del teatro politico newyorkese. Assecondando una fede politica mai sopita e giammai rinnegata, nel 1935 intraprende un viaggio di studio in Unione Sovietica. A Mosca, frequenta i seminari di regia di Sergej Ejzenštejn, conosce Bertolt Brecht. Il drammaturgo e poeta tedesco sarà una figura chiave per la sua formazione artistica. Tra il 1946 e il 1947 i due si ricongiungono a Los Angeles; lavorano a un grande allestimento di Vita di Galileo. Nei panni del fisico pisano, il grandissimo Charles Laughton. Il 30 luglio 1947 è il giorno della prima, al Coronet di Beverly Hills. Esattamente tre mesi più tardi, Brecht sarà convocato a Washington dalla Commissione per le attività antiamericane. Lascerà gli Stati Uniti il giorno successivo.
Nella primavera del 1951, la caccia alle streghe tocca anche Losey. Iscritto al Partito comunista degli Stati Uniti dal 1946, è da tempo un osservato speciale. Nel 1948 è approdato al cinema. L’esordio prende le forme di un piccolo film in Technicolor, un poetico apologo pacifista, alquanto didascalico (Il ragazzo dai capelli verdi); nel 1951 la sua firma compare su tre pellicole: un intelligente remake di M – Il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang (M) e due capolavori del noir americano, Sciacalli nell’ombra e La grande notte. Proprio durante le ultime fasi di montaggio di quest’ultimo, deciderà di abbandonare gli Stati Uniti: l’aria, dopo la pronuncia del suo nome da parte di un teste in Commissione, si è fatta irrespirabile.
Tra il 1951 e il 1952 è in Italia, gira Imbarco a mezzanotte per la United Artists. I titoli di testa ci informano che la regia è di Andrea Forzano, ma è una copertura. Nel gennaio del 1953 si stabilisce a Londra. In Regno Unito, la sua carriera conoscerà una rinnovata fortuna. Un altro uomo di teatro, dopo Brecht, segnerà questa fase: Harold Pinter, un discepolo di Beckett, maestro della commedia psicologica e dello slow burn, con un gusto particolare per il grottesco. L’incontro fra due personalità apparentemente distantissime – Losey un prodotto dell’Ivy League, Pinter il figlio talentuoso di un modesto sarto dell’East End londinese; Losey un cinquantenne, Pinter un trentenne; Losey un regista barocco e melodrammatico, Pinter un drammaturgo trattenuto e allusivo – genererà tre film straordinari: Il servo (1963), L’incidente (1967) e Messaggero d’amore (1971).
Tony Mounset (James Fox), un annoiato rampollo della vecchia aristocrazia inglese, assume un maggiordomo-tuttofare (Dirk Bogarde) per gestire una nuova proprietà nel quartiere di Chelsea. Il sottoposto, con modi via via più serpentini, sovverte lentamente la gerarchia, trasformando la casa nel campo di battaglia di un’atavica lotta di potere. Questo il canovaccio attorno al quale ruota Il servo. È facile, a prima vista, riconoscervi il côté marxiano di Losey, sostanziato in un’allegoria del conflitto di classe. La visione del regista americano, tuttavia, è del tutto priva di quell’afflato escatologico – in fin dei conti, cristiano – che Karl Löwith correttamente rilevava nella filosofia della “salvezza comunista” di Marx: la lotta di classe per Losey non è il viatico nella strada della pace sociale, ma un’impasse eterna e sanguinosa, dalla quale nessuno esce vivo.
La dialettica servo-padrone è traslitterata nelle forme del barocco. Gli specchi segnalano identità e ruoli scissi, le scale sovvertimenti gerarchici, le ombre il gioco delle maschere. L’erotismo riconduce alla politica delle pulsioni, all’etica del dominio territoriale: il sesso come surrogato della masturbazione e non viceversa (Groddeck), come disciplina tattica in zona di guerra, per l’affermazione personale sul nemico. All’epoca, la descrizione inacidita di un’alta borghesia perversa e decadente parve un riflesso dell’attualità: il 1963, per gli inglesi, è l’anno dell’affare Profumo. Più profondamente, il tema dello straniero che si introduce in terra d’altri e sconvolge – anche sessualmente – gli encori è una filiazione tragica: alla sua fonte stanno le Baccanti di Euripide – torneranno utili anche a Pasolini per Teorema e il suo Terence Stamp-Dioniso. Di qui l’universalità che ci sentiamo di attribuire al Servo.
Tutto considerato, è forse la dimensione del gioco quella più adatta ad accorpare le istanze tematiche del film. Un gioco bambinesco, dunque spietato. Nella casa vuota, le suppellettili diventano le pedine della partita a scacchi tra i due contendenti. Non vi sono vincitori né vinti, al termine del massacro. Dacché quell’universo chiuso – da cui la cinepresa di Losey fuoriesce soltanto tre, significative volte – è tanto microcosmo quanto prigione. Dentro, ci siamo anche noi spettatori, intrusi per eccellenza nelle storie altrui, impotenti – quindi sconfitti – nel gioco del cinema da-per sempre. All’uscita – paradossale uscire da un film che è una teoria sull’impossibilità di farlo –, qualcuno si sarà chiesto qual è il senso del tour de force di Hugo Barrett. Qual è la finalità. Baudrillard risponderebbe che, se il gioco avesse una qualsiasi finalità, il solo vero giocatore sarebbe il baro.